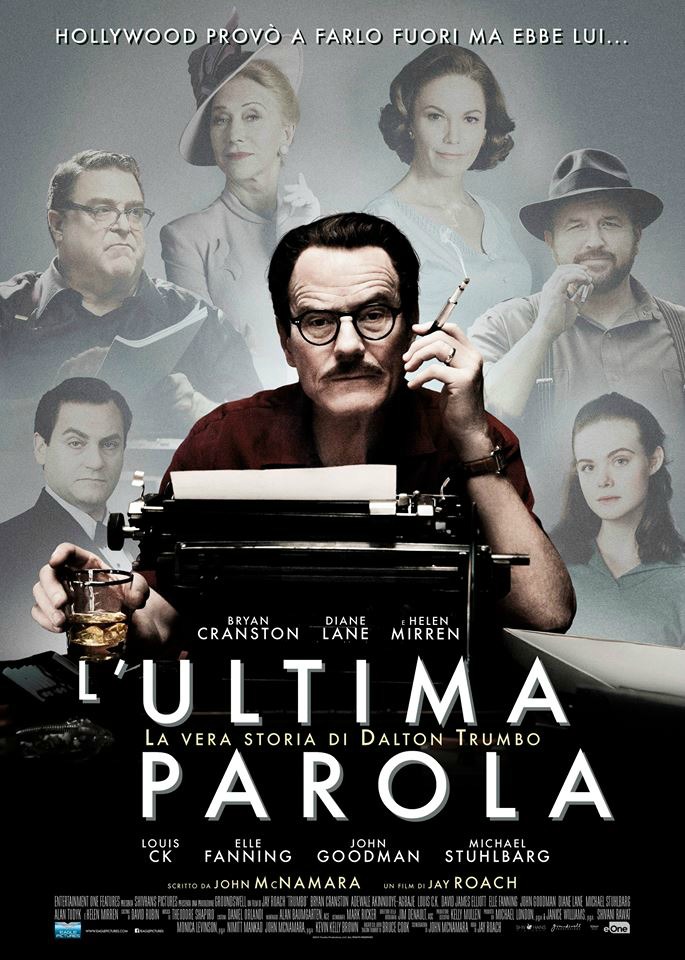Alice Cooper è balzato in cima alla lista di artisti che si sono guadagnati sul campo la mia stima perpetua dopo un concerto, quello in cui ha aperto per i Motley Crue, nel quale la sua classe, le sue doti di entertainer e il suo leggendario repertorio hanno abbagliato tutti i presenti. E pensare che fino a quel momento lo consideravo un mezzo fenomeno da baraccone che ormai aveva sparato da decenni le cartucce migliori. E' proprio vero che i musicisti devi vederli dal vivo per giudicarli.
Nel corso di quest'anno il quasi settantenne rocker (nasce a Phoenix nel febbraio del 1948) rilascia Paranormal, il ventiseieseimo album della sua carriera, filosoficamente nel solco, e lo si capisce fin dalla copertina, della cifra stilistica da lui stesso plasmata.
Sono sufficienti le atmosfere della title track che apre il lavoro per essere infatti proiettati nel mondo oscuro e gotico di Alice: il pezzo, scritto assieme a Roger Glover dei Deep Purple, che vi suona anche il basso, è una mini suite orrorifica di poco più di quattro minuti, divisa in due movimenti, che si cristallizza tra le cose migliori del disco.
Così come svetta il mood ai limiti dello stoner di Fireball, il puro ZZ Top boogie rock di Fallen in love (ospitata di Billy Gibson on guitar) e il soul-rock festaiolo con corredo di fiati di Holy water. Mettiamoci poi una Paranoiac personality così legata alla tradizione sonora di Cooper da risultare quasi un auto plagio (di Go to hell) e la sorprendente conclusione pinfloydiana di The sound of A e il piatto è servito.
Oltre agli ospiti già citati, sono della partita il produttore e musicista Bob Ezrin e il batterista degli U2 Larry Mullen jr (che suona in nove brani su dieci).
La tracklist di dieci pezzi, per un totale di meno di trentacinque minuti di durata, è dosata e bilanciata alla perfezione, anche se c'è in giro la solita deluxe edition con due bonus tracks e una manciata di pezzi storici dal vivo.
Un disco indubbiamente di mestiere, ma a cui non manca però una dose non comune di orgogliosa dignità.