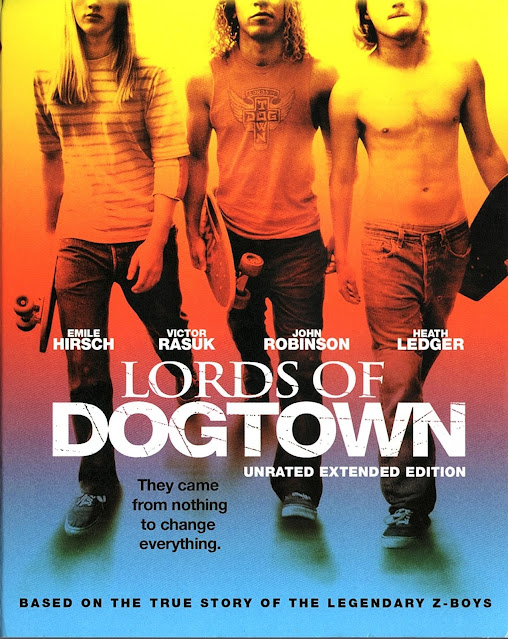Al tramonto dell'estate del 1987 arriva nei negozi il singolo che anticipa l'uscita di Tunnel of love. Si tratta di Brilliant disguise, un brano che dal punto di vista musicale non solo non ha niente a che vedere con Born in the USA, ma disconosce tutta la produzione antecedente di Springsteen. L'arrangiamento della ballata è impostato su di un loop che poggia soprattutto sulla nota LA, alternata nelle sue modalità maggiore, seconda e quarta. Sebbene costruita in maniera canonica (strofa/ritornello/bridge) si ha la percezione che la traccia abbia un unico (per me ipnotico, per altri monotono) pattern, dall'inizio alla fine. Il testo anticipa la penombra emotiva di quello che sarà il lavoro completo. Dubbi sull'autenticità dell'amore provato e ricevuto e sospetti di tradimento ne caratterizzano infatti il portato. Sul lato B del singolo l'oscurità si infittisce, con una spettrale Lucky man (outtake che resterà fuori dalla tracklist dell'album), a riecheggiare Nebraska.
Ed eccoci finalmente al "pacchetto completo" di Tunnel of love: dodici tracce che rappresentano (per chi scrive) un malinconico, meraviglioso, controverso viaggio introspettivo negli spazi che intercorrono dentro un rapporto di coppia. Mai prima (e mi ripeto, mai dopo) un disco di Springsteen era stato così monotematico, quasi un concept sul dilemma del sentimento più nobile e affannosamente cercato dall'animo umano, fotografato in una condizione sospesa in cui, neanche fossimo nello splendido film Pixar Inside out, convivono ricerca della felicità, gelosia, momenti di esaltazione, malinconia, fiducia verso il partner ed assenza di essa.
E subito, con Ain't got you, l'incipit del lavoro, veniamo catapultati in questa dimensione di ombre (tante) e luce (poca). Nell'errebì alla Bo Didley, il Bruce fresco di matrimonio con la top model ci dice che ha tutti i beni materiali che un uomo possa desiderare (I got all the fortunes of heaven in diamonds and gold/ I got all the bonds baby that the bank could hold ) ma gli manca l'amore (But the only things I ain't got, baby/ I ain't got you) , quasi che, invece che un neo sposo, a cantare sia uno spasimante non corrisposto. Il testo, sebbene per tematiche rientri in una solida tradizione allegorica propria del rockabilly fifties, è talmente autobiografico nella sua disamina della condizione borghese di Bruce (I got house full of Rembrandt and priceles art (...) / I been around the world and all across the seven seas / Been paid a king's ransom for doin' what comes naturally) da provocare il rigetto "filosofico" dell'amico Little Steven, cui il brano viene fatto ascoltare in anteprima (c'è da dire che l'ex chitarrista della E Steet all'epoca era all'apice del suo afflato artistico di intransigente denuncia politico-sociale al sistema americano), e che gli rimprovera - a mio avviso con eccessiva severità - un inaccettabile imborghesimento.
I due pezzi successivi sono gli unici del lotto che possiamo definire happy love songs. Se per Ain't got you, dal punto di vista stilistico, siamo al cospetto di un ritorno alle origini, alle passioni musicali giovanili di Bruce (non a caso dal vivo verrà proposto in un azzeccatissimo medley con She's the one) per Tougher than the rest è tutta un'altra storia. La batteria di Max Weinberg ha infatti un incedere marziale autoritario, che viene però subito addolcito da una chitarra country honky tonk, e una melodia sinuosa che serve a Bruce per dire alla sua amata If you're looking for love, honey I'm tougher than the rest. Di come il pezzo venga scritto per una donna e diventi poi lo strumento con cui si celebra l'amore per un'altra ho già detto, quindi vado oltre.

Si diceva dei rumors che volevano Bruce pubblicare un disco country, ebbene pur non corrispondendo questo a verità, c'è indubbiamente una fascinazione honky tonk che emerge a differente intensità in due tre brani. Se in Tougher then the rest questa intensità è solo accennata nell'arrangiamento di chitarra, si palesa senza timore in All that heaven will allow (ripresa non a caso dai Mavericks), secondo e ultimo brano in cui emerge l'aspetto più romantico ed esaltante, gioioso della relazione sentimentale. Con When you're alone chiudiamo in bellezza il cerchio country, attraverso un arpeggio che in quell'ambito trova la sua collocazione, un testo e un cantato che non cerca mediazione musicale alcuna. Una country song fatta e finita insomma, scarna e malinconica come da tradizione, in cui il titolo dice tutto. Mi sono sempre stupito che uno come Johnny Cash, che pure ha più volte coverizzato Bruce (Highway patrolman; I'm on fire; Johnny 99, Further on up the road) o uno come Willie Nelson, per la cui voce il pezzo sembra scritto, non abbiano mai pensato di fare propria questa canzone alla Hank Williams.
E poi ci si addentra nelle paludi dei dubbi di un uomo insicuro e lacerato dai tormenti. La lista dei titoli in cui Springsteen si psicanalizza è corposa, a partire dallo scarno folk di Cautious man dove racconta di Billy Horton, un uomo che vive sospeso, irrealizzato, una condizione condensata in due parole, LOVE e FEAR, tatuate una su ciascuna nocca delle mani (rielaborazione cinematografica dello spaventoso Mitchum de La morte corre sul fiume). Non sfugge alle tribolazioni springstiniane nemmeno la caleidoscopica title track, che, attraverso un massiccio uso di sintetizzatori, realizza la vertigine tipica della giostra in movimento, e con essa le tante insidie di una relazione stabile (It ought be easy / ought to be simple enough / Man meets woman and they fall in love / But this house is hounted and the ride get rough ).
Per chi scrive l'apice del disco è One step up, una ballata anch'essa malinconica e di struggente solitudine sebbene nell'ambito di una vita a due, fotografia di un uomo che fa un bilancio della sua vita (When I look at myself I don't see / The man I wanted to be) mentre il suo matrimonio sprofonda in una routine di incomprensioni. Voglio anche in questo caso segnalare un passaggio del video che ha accompagnato la release del singolo, nel punto in cui vediamo Bruce fantasticare su un adulterio e un istante dopo la mdp inquadrare la fede al suo dito, una sequenza sottolineata dal testo (There's a girl across the bar / I get the message she's sendin' / Mmmh she ain't lookin' to married / And me, honey I'm pretending).
Un passaggio che, con brutale onestà, fotografa, trovando una forma di ironia dentro un contesto di disillusione, una condizione decisamente comune per molti uomini sposati. L'unico pezzo dell'intera raccolta di canzoni che va a riallacciarsi con il blue collar rock, sebbene più aspro del recente passato, è Spare parts. Ma anche qui, se la musica si fa più sferzante, il tema resta quello della solitudine causata dall'abbandono, stavolta visto però nell'ottica di una donna lasciata dal suo uomo dopo la scoperta di una gravidanza. Non a caso, credo, nel rovesciamento dei ruoli che vedono passare il POV da uomo a donna, l'epilogo della canzone muta, trovando riscossa e speranza.

L'elemento principale, forse l'unico, che rende l'autobiografia Born to run, una lettura importante per farsi strada nella psicologia springstiniana, è la rivelazione di una forma patologica di depressione, ereditata dal padre, di cui Bruce rivela di avere sempre sofferto. Una depressione che, per usare le sue parole, arriva violenta ed improvvisa, implacabile e inarrestabile come un treno in corsa. Nel 1987 non lo sapevamo, e abbiamo pensato che Two faces, da un certo punto di vista una canzone minore, di raccordo, si rifacesse unicamente ai problemi sentimentali fil rouge dell'album. Col senno di poi il pezzo acquisisce un senso enorme, figurandosi come una criptica rivelazione al mondo esterno del male di vivere che attanaglia il Boss quando è giù dal palco. Il testo, da questo punto di vista, è inequivocabile: "Sometimes mister I feel sunny and wild / Lord I love to see my baby smile / Then dark clouds come rollin' by / Two faces have I / One that laughs one that cries /One says hello one says goodbye / One does things I don't understand / Makes me feel like half a man".
Come detto, Tunnel of love è un unicum nella produzione springstiniana. Per certi versi (l'introspezione della maggior parte delle composizioni, l'essenzialità di molti arrangiamenti) guarda a Nebraska, ma per altri, come ad esempio lo sguardo disilluso sulla convenzione sociale del matrimonio e sulla fragilità delle relazioni, si riallaccia ad una parte di composizioni di The river, la title track su tutte (ispirata dalla sorella), che gettavano sulla condizione matrimoniale ombre e incertezze. Stavolta ad interrogarsi sul tema non è un più un giovane uomo che parla delle esperienze altrui, ma un adulto finito che riflette su se stesso, sul proprio, di matrimonio. E se per il mio personalissimo gusto One step up è l'highlight dell'album, c'è un'altra canzone a cui sono legatissimo da sempre, che da sempre ho sentito vibrare nelle mie corde più profonde ed intime. Si tratta di Walk like a man, che viaggia sulle ali leggere della nostalgia, della dolcezza, della malinconia, della purezza del sentimento, mentre celebra il giorno "più bello". Un pezzo che, idealmente, nella mia personale macchina del tempo, ha fatto da ponte al me stesso che nel 1987 si sentiva in uno stato di grazia e che oggi, per ragioni diverse, sente ancora più sue le parole di quel testo.
Ma in fin dei conti l'identificazione con Tunnel of love è solo la manifestazione di un sintomo, una patologia, una relazione non comune con la musica che, per ragioni ignote, non è quello che accompagna la stragrande maggioranza delle persone, attraversate da una fase della vita, quella del passaggio tra adolescenza ed età adulta, nella quale questa arte ha (oppure aveva, non saprei) un ruolo predominante ma decisamente temporaneo, che si conclude e viene quindi accantonato nel giro di un lustro o giù di lì.
Per qualcuno di noi invece, nemmeno il subentrare di oneri e responsabilità connessi alla crescita riesce a scalfire questo rapporto di dipendenza, questa connessione che ci porta, da sempre e ogni giorno che sorge il sole, a dedicare una parte variabile di tempo ad un'immersione fanciullesca in un abisso di note (con o senza parole). Un universo nel quale ognuno ha i suoi luoghi musicali dell'anima nei quali ciclicamente torna e ritorna. Per me Tunnel of love è uno di quelli, sono sicuro che anche tu hai i tuoi, e che li tieni stretti a te come frammenti di sciocca ma irrinunciabile felicità.
qui la prima parte