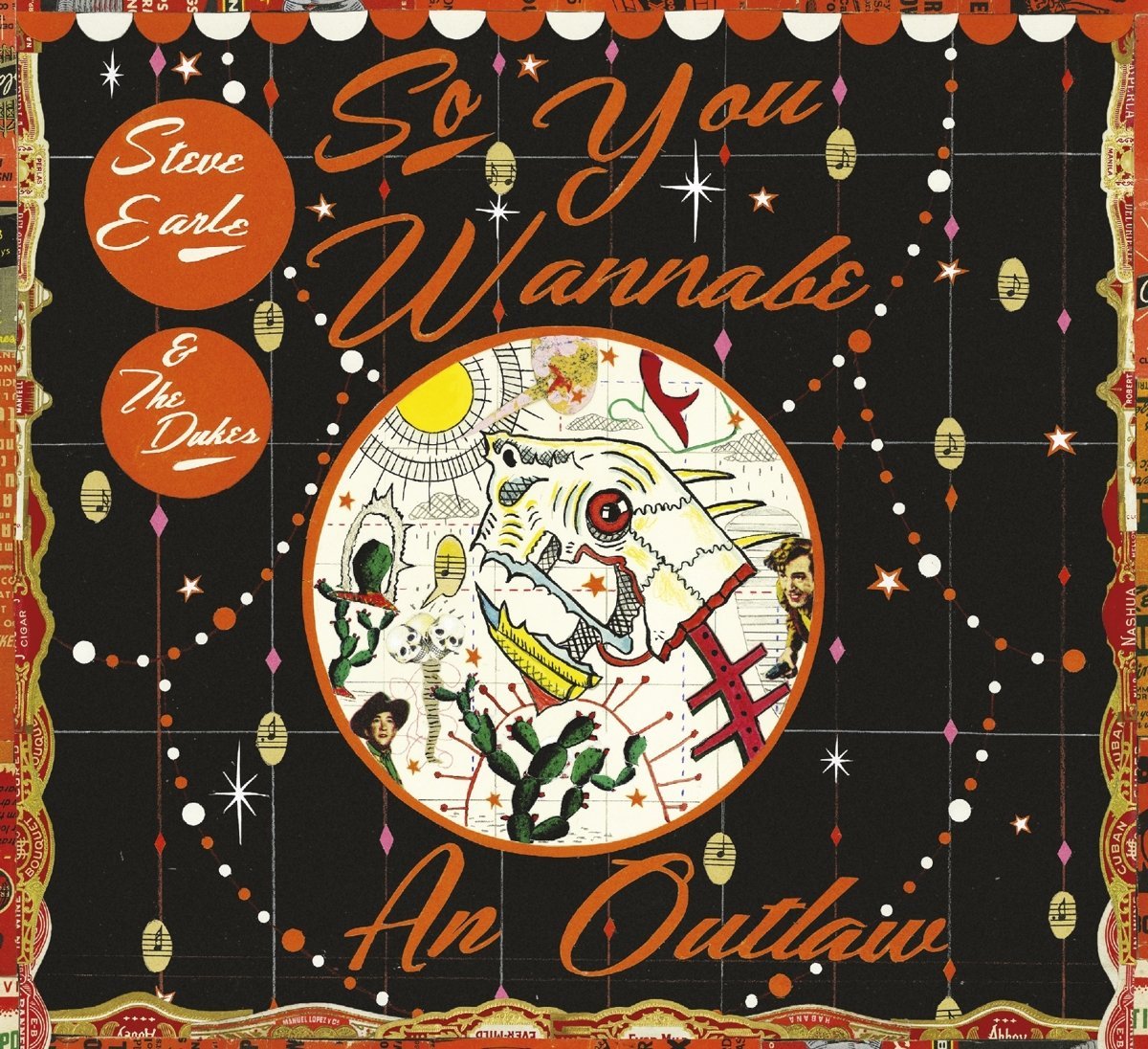Un dollaro d'onore (Rio Bravo in originale, superato per una volta in efficacia dal titolo italiano) nasce come progetto dichiaratamente mainstream: è sviluppato cioè per riempire i cinema dell'epoca.
Nonostante ciò, il film racchiude in sè tanti elementi che lo elevano verso l'autorialità: aspetti tecnici ma anche storie personali dei singoli artisti coinvolti, oltre ad un'enorme eredità tematica.
Partiamo dal regista, il mitologico Howard Hawks, director fondamentale nella storia del cinema americano (e non), partito a girare con il muto nel 1926 e autore di innumerevoli capolavori che spaziano nei generi più disparati (a mero titolo esemplificativo: Scarface, L'idolo delle donne, Viva Villa!, Il mio corpo ti scalderà, Il grande sonno, Il fiume rosso, Gli uomini preferiscono le bionde) , ma che veniva da un fiasco clamoroso (La regina delle piramidi, 1955) per il quale si era imposto un periodo di auto esilio a Londra durato ben quattro anni.
Quando decide di rimettersi dietro alla macchina da presa sceglie il canone del western, un genere che, sembra incredibile a dirsi oggi, nel 1959 sembrava finito. Hawks invece riparte proprio da lì e dalla leggenda che da sola lo rappresenta: un John Wayne cinquantenne e non più scattante nel fisico, ma sempre di grande carisma, attorno al quale gira tutto il film.
Il film è pensato per il grande pubblico, come scritto in premessa, ma inizia con modalità che più d'autore non potrebbero essere. I primi cinque minuti si svolgono infatti in assenza assoluta di dialoghi. Un ottimo Dean Martin (Dude) entra nel saloon livido, con gli abiti lisi e in preda agli spasmi causati dalla crisi di astinenza all'alcol, a mendicare un goccio di torcibudella. Gli avventori lo deridono, e uno di essi, per spregio, gli getta un dollaro nella sudicia sputacchiera sul pavimento. Dude si getta senza indugio a recuperarlo ma qualcuno glielo impedisce, calciando via il vaso. A questo punto, con Martin inginocchiato a terra, l'inquadratura dal basso riprende John Wayne (lo sceriffo John T. Chance) in tutta la sua magnificenza, quasi fosse un dio, a sovrastare disgustato la miseria umana di Dude e dei miserabili avventori. La tensione di questa scena ancora oggi meravigliosa è tutta costruita esclusivamente su sguardi, fisicità, movimenti di macchina e musiche.
Addentrandoci nella trama, scopriamo poi che Dude era il vice di Chance, che, a causa di una delusione amorosa, è scivolato nella spirale dell'alcolismo, lontano da Rio Bravo. E' tornato, ancora segnato dalla dipendenza, proprio nel momento in cui nelle galere cittadine è custodito per omicidio, in attesa di essere prelevato dall'esercito, il fratello di Nathan Burnette, un ricco possedente del luogo, a capo di una gang violenta e senza scrupoli. I due, insieme al vecchio malconcio Stumpy (Walter Brennan, caratterista noto per l'interpretazione di questi ruoli) e al giovanissimo Colorado (il crooner Ricky Nelson, allora diciottenne idolo delle teen agers) subiranno un assedio da parte di Burnette e i suoi uomini, all'inizio più psicologico che reale, che deflagrerà (letteralmente) nel finale. Da segnalare anche la parte di una acerba, bellissima e sensuale Angie Dickinson, nel ruolo non banale di donna sola, ma forte e indipendente, ai cui piedi cadrà il burbero John Wayne.
Ma Un dollaro d'onore, oltre al suo valore oggettivo, è unanimemente considerato anche l'indiscusso capostipite di una dinamica narrativa, quella dell'assedio (a un palazzo, una casa, una città, un territorio), che ha generato un enorme sotto-filone indiscutibilmente guidato dal grande John Carpenter (da Distretto 13 in avanti).
Come prassi consolidata, mi piace concludere la recensione con un riferimento musicale. Hawks infatti, potendo contare nel cast su crooner del livello di Martin e Nelson, decide di sfruttare a pieno le loro capacità. Anche in questo caso però la sequenza in cui si evidenziano le doti canore dei due non è buttata via, serve a congelare la narrazione e a cementare il cameratismo dei quattro eroi. Con Dean Martin a cantare alternandosi a Ricky Nelson, che suona anche la chitarra, e Brennan all'armonica (John Wayne si limita ad ascoltare compiaciuto) vengono eseguite My rifle my pony and me, classica lenta cowboy song e Cindy, un pezzo più ritmato afferente al country blugrass (qui il link della sequenza).
Cinema d'altri tempi, che, nonostante i quasi sessantanni di invecchiamento, ad ogni visione restituisce intatta la sua magia.