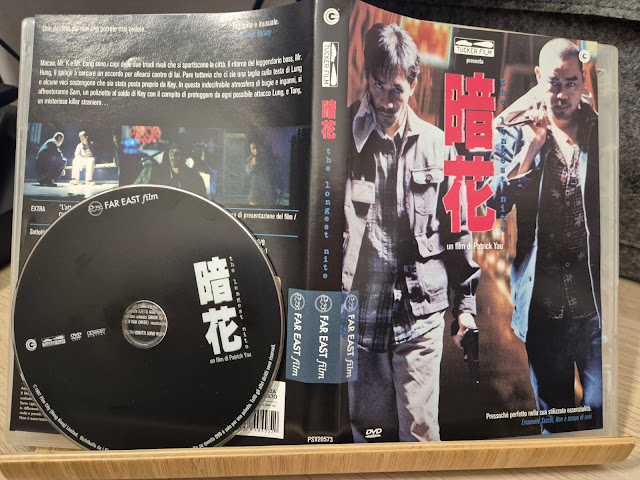In premessa lasciami esporre un concetto che mi guida in relazione ai film che si pongono un obiettivo di denuncia politico-sociale: non sempre l'encomiabile proposito degli autori si traduce in cinema di qualità. Si potrebbero fare davvero tanti esempi di pellicole "impegnate" che si sono rivelate mediocri o proprio brutte. In ogni caso, specialmente in un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con la marea nera delle peggiori destre che sta avanzando come il Nulla de La storia infinita, è senza dubbio apprezzabile il coraggio di esporsi.
In questo caso di esporsi con una persona che, se da qui a circa due settimane dovesse tornare ad essere presidente degli Stati Uniti (prospettiva purtroppo probabile, visto un meccanismo elettorale risalente al 1787), ha già ampiamento anticipato che il suo sarà un governo di "retribution", vale a dire ritorsivo e vendicativo nei confronti dei suoi avversari. E di certo Ali Abbasi, regista iraniano naturalizzato danese (si parla tanto di Holy spider, grande film, meno del disturbante, gotico, fiabesco Border) di motivi per scatenare la faida trumpiana, con questo The apprentice, ne offre tanti, all'ossigenato ex palazzinaro newyorkese.
Com'è noto, la storia prende in esame la formazione di Trump, partendo dalla New York sporca e decadente della metà dei settanta, fino alla notorietà e alla costruzione della Trump Tower (chiaro esempio di compensazione fallica, se mi passi la battuta). Molto spazio, nella fase giovanile del futuro presidente, è data alla figura di Roy Cohn, ex procuratore sciovinista e maccartista nei cinquanta e successivamente avvocato di successo che usa spregiudicatamente ricatti e minacce. Lo impersona Jeremy Strong, un attore che, al netto della notorietà derivata da Succession, è probabilmente qui al suo primo ruolo davvero caratterizzato e non butta via l'occasione, con una prova che si fa ricordare. Lo stesso vale per Sebastian Stan che, soprattutto nella seconda parte del film, quella in cui emerge il Trump cinico e spietato che abbiamo imparato a conoscere, ci regala un'interpretazione maiuscola, eludendo con bravura il rischio parodia.
Dopo tutto, come ci ricorda Ellroy (repubblicano dichiarato): l'America non è mai stata innocente.
La sceneggiatura (Sherman) ci racconta in parte fatti storici acclarati, come il rifiuto di Trump affittare case agli afroamericani, e in parte decide di forzare su alcune vicende controverse e mai del tutto confermate, dagli aspetti narcisistici, come quello della liposuzione e dell'intervento tricologico, a quelli ben più gravi e penalmente rilevanti, come lo stupro ai danni della prima moglie Ivana (che la stessa prima denuncia e poi, molti anni dopo, ritratta) o il tentativo di far sottoscrivere al padre con problemi neurocognitivi un atto amministrativo per far mettere a Donald le mani sul fondo di famiglia e coprire così i suoi tanti buffi.
Il film vola senza momenti di stanca, infatti, al suo epilogo dopo due ore, quando si arriva al Trump spietato, cinico e senza scrupoli che detta la sua biografia ad un giornalista, vorresti averne ancora.
The apprentice, arrivato nelle sale dopo battaglie legali che hanno tentato di impedirne la diffusione, pare sia stato fin qui un flop (annunciato), la speranza è che lo streaming gli restituisca la visibilità che penso meriti, e non perchè possa essere uno strumento per la sconfitta elettorale di Trump (al contrario, io penso che in questo senso l'operazione sia controproducente), ma perchè ci troviamo di fronte ad un titolo che salda impegno e qualità. E come scrivevo in premessa, non capita spesso.