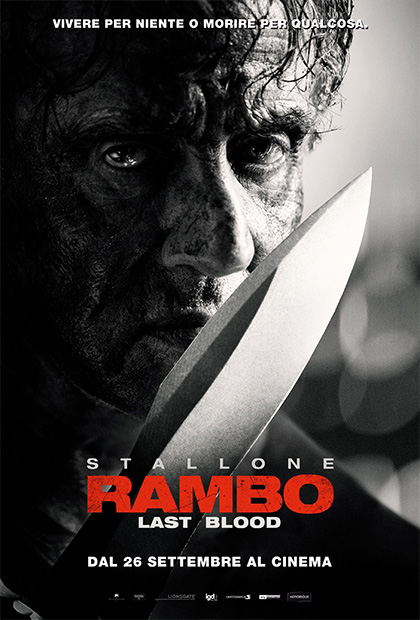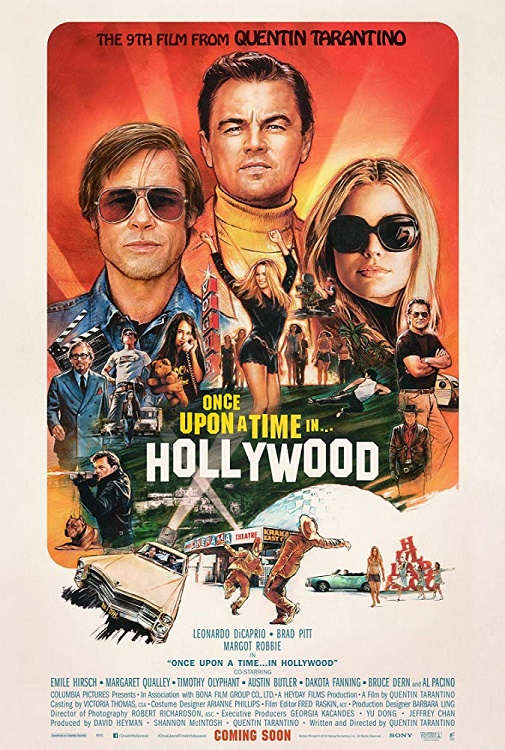E' mia ferma convinzione che lo Springsteen degli ultimi scarsi quindici anni abbia musicalmente vivacchiato, con l'ispirazione che si accendeva ad intermittenza come una vecchia lampadina della cantina che per pigrizia non ti decidi a sostituire.
Credo altresì che dischi davvero brutti non ne abbia mai fatti (se volete, qui trovate le recensioni di Magic; Working on a dream; Wrecking ball; High hopes), ma, dopo il riuscitissimo esperimento irish-folk di We shall overcome (forse il migliore Bruce degli anni zero assieme a The rising), l'impressione forte è sempre stata quella di album raccogliticci, senza un preciso filo conduttore, con pezzi più che dignitosi (qui ho provato a mettere insieme il meglio del periodo 2007-2014) abbinati a tracce che in passato avrebbero rappresentato oneste B-sides.
Paradossalmente, il succitato periodo è stato anche quello più ingolfato di uscite, quattro in sette anni, come non accadeva dagli esordi dei settanta, senza contare le riedizioni espanso-celebrative di Born to run, Darkness on the edge of town e The river, i tour con annesse copiose pubblicazioni di dischi dal vivo, l'autobiografia e un anno di repliche a Broadway del suo spettacolo più intimo. Insomma, l'uomo non è rimasto mai troppo fermo, eccezion fatta per la pubblicazione di inediti, rispetto ai quali Springsteen ha fatto passare cinque anni per decidersi a sfornare il successore di High hopes (2014).
Successore che s'intitola Western stars ed esce a metà giugno e, sì, io ne sto parlando negli ultimissimi giorni dell'anno, oltre sei mesi dopo.
La ragione va oltre l'attenzione speciale che ancora oggi metto nel recensire i lavori di Bruce, ed attiene invece alla lenta sedimentazione dell'opera, partita piano, in maniera quasi respingente e poi letteralmente esplosa a livelli e frequenze d'ascolto mai più raggiunte dai tempi del tributo a Pete Seeger.
La ragione va oltre l'attenzione speciale che ancora oggi metto nel recensire i lavori di Bruce, ed attiene invece alla lenta sedimentazione dell'opera, partita piano, in maniera quasi respingente e poi letteralmente esplosa a livelli e frequenze d'ascolto mai più raggiunte dai tempi del tributo a Pete Seeger.
Si, perchè con questo disco improvvisamente Springsteen ritrova sè stesso, un credibile storytelling e quel fil rouge che lega assieme le composizioni, rappresentando l'unicità dell'opera-album, a differenza delle raccolte di pezzi coagulati artificialmente, senza la necessaria alchimia.
Tornano le storie dello Springsteen che abbiamo imparato ad amare, i suoi personaggi, i meravigliosi losers impigliati nella fitta ragnatela che permette di intravvedere da lontano il Sogno Americano, ma che, è certo, impedisce ai più di toccarlo, di raggiungerlo (Drive fast (The stuntman); Hitch hiker; The wayfarer ).
Del mood musicale ne sono state scritte davvero di tutti i colori, a me sembra molto semplice, e cioè che Western stars sia essenzialmente costruito in buona parte sul classico ed inconfondibile folk springstiniano, con il valore aggiunto di qualche riuscito innesto di orchestrazioni più sinfoniche e "cinematiche" nelle quali rieccheggia Roy Orbison (There goes my miracle), e forse Marty Stuart, ed altre dove emerge il tipico timbro dell'ormai fido produttore Ron Aiello (Tucson train).
Di certo a me sembra che mai (negli ultimi anni) come in questo caso si torni ai massimi livelli in quanto a liriche, con capolavori nascosti come Stones, grandi pezzi come Hello sunshine (difficile non ritrovarci il rapporto con la sua depressione); Drive fast, Somewhere out of Nashville, che svettano dentro una media complessiva comunque d'eccellenza.
A tutto ciò si aggiunga l'incredibile maturazione raggiunta dalla voce di quest'uomo, elemento che molti danno per scontato ma che scontato non è, per capire che siamo davvero in presenza di un disco speciale.
Tutt'altro discorso è la parte definiamola commerciale dell'operazione nuovodiscodispringsteen, a partire dalla decisione, tristemente ricorrente, di ristampare il cd a pochi mesi dall'uscita, con la scusa dell'integrazione con un disco dal vivo (in questo caso soundtrack del film documentario) nel tentativo di "imporre" ai fans completisti il doppio acquisto. Non esente da critiche anche il look posticcio di un "Boss" fotografato nel deserto, agghindato da cowboy in pose molto, troppo, perentorie, per finire con l'ennesima scelta poco convincente e a tratti inspiegabile dell'immagine per la copertina del disco. Quanto sarebbe stata più efficace, psichedelica e misteriosa la foto del sole che deforma i contorni dei joushua tree presente sulla quarta di copertina del booklet del cd (la posto qui sotto)? D'altro canto per quanto concerne questi aspetti (immagine e copertine dei dischi) davvero il buon Bruce non ne azzecca una da tempo immemore.
Ce ne faremo una ragione, soprattutto in questo caso, si tratta di elementi del tutto marginali.
Ciò che davvero, davvero, conta è che Western stars rappresenta, finalmente, il gran bel disco che aspettavi da tempo. L'album del ritorno di un artista che quest'anno ha compiuto settanta anni e, se vogliamo essere onesti, non ci sono molti altri (quasi) coetanei, dall'inarrivabile Dylan a Neil Young, che a quest'età abbiano rilasciato dischi così intensi, credibili ed ispirati (forse giusto l'ultimo Bowie).
Insomma, credeteci o no, Springsteen nel 2019 ci ha regalato un album da ricordare.