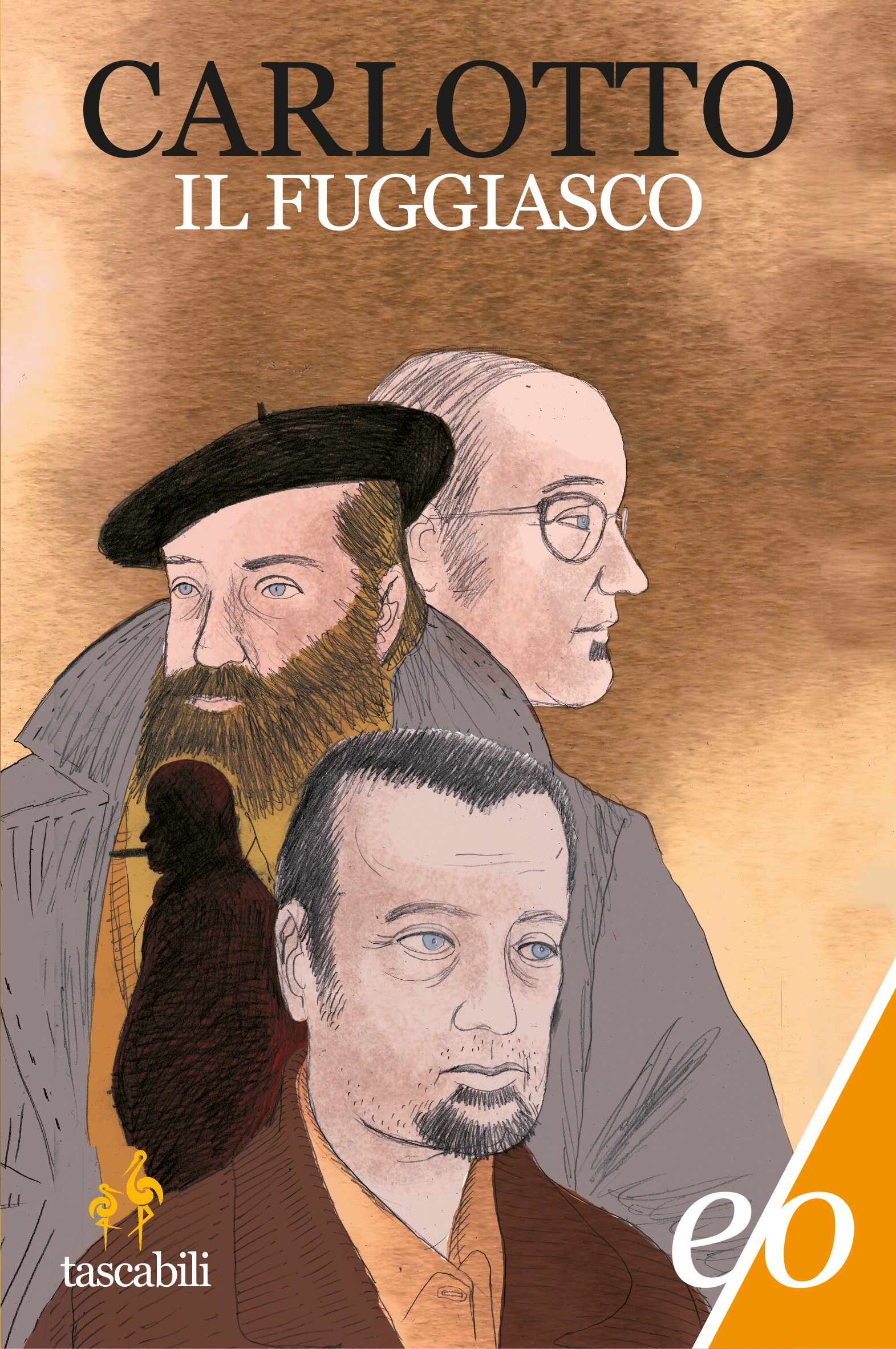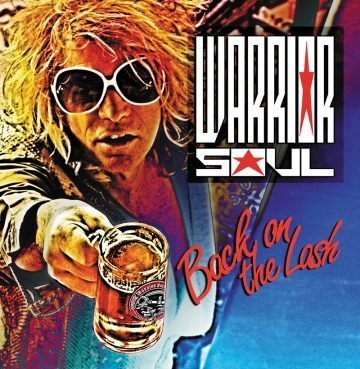
Nella storia della musica rock ci sono state e sempre ci saranno band che, pur avendo tutti i numeri per raggiungere la piena affermazione di critica e pubblico: sound, testi, personalità, immagine, restano ai margini della grande popolarità. Per come la vedo io, i Warrior Soul sono una delle grandi icone di questa ingiustizia. Certo, non aiuta il livello di competizione con il quale si è trovato a misurarsi il gruppo, se pensiamo che tra il 1991 e il 1992, anni di uscita dei due capolavori dei WS (Drugs, God and the new republic e Salutations from the ghetto nation) il rock sfornava alcune tra le più importanti pietre miliari degli ultimi trent'anni: l'esordio di Pearl Jam e Rage Against The Machine, Nevermind dei Nirvana, Blood Sugar Sex Magic dei RHCP e Vulgar display of power dei Pantera, giusto per citare i primi che mi sovvengono. E i Warrior Soul, che non erano inquadrabili nè nel pompatissimo filone grunge, nè nell'agonizzante (ma si sarebbe ripreso) bacino metal, dovevano masticare pane duro.
Una discriminazione dalla quale non si sarebbero più ripresi: se all'apice della loro ispirazione, con le canzoni anarcoidi, punk, indipendenti, orgogliose e bellissime contenute nei due album sopra citati (e aggiungo in Chill Pill e in The space age playboys del 1993 e 1994) non si sono smossi i riscontri auspicabili, era difficile ipotizzare successivi exploit.
Per questa ragione ogni volta che Kory Clarke, singer, frontman e leader indiscusso della band, riesce nell'impresa di incidere un nuovo lavoro, il voto di partenza è, a prescindere, un 7.
Lo premetto perchè in questo Back on the lash sarebbe più facile avanzare critiche che lodi: il suono è diventato più semplice e diretto e di conseguenza spersonalizzato, si sono perse quelle atmosfere dilatate tendenti al psichedelico che facevano da congruo contraltare alle mazzate in faccia dei pezzi più tirati, in alcuni passaggi si odono addirittura echi di AC/DC (la title track e Black out), ma, davvero, chi se ne sbatte, certe volte per come la vedo io bisogna azzerare la parte critico-razionale e limitarsi a muovere il culo a tempo di rock 'n' roll. E questo disco il fondoschiena lo fa muovere in maniera spontanea, con l'aggiunta di testi che menano fendenti all'atrofizzata società americana, nel nome di un'anarchia comportamentale che, vista l'età di Kory, sarà anche affievolita, ma che va sempre bene. La breve ma incisiva opener (American idol) , la trascinantissima I get fucked up e via via fino alla conclusiva That's how we roll ci consegnano un'opera breve (poco più di mezzora di musica) ma tostissima e una band che non vuole saperne di rassegnarsi al fato avverso.