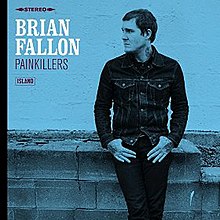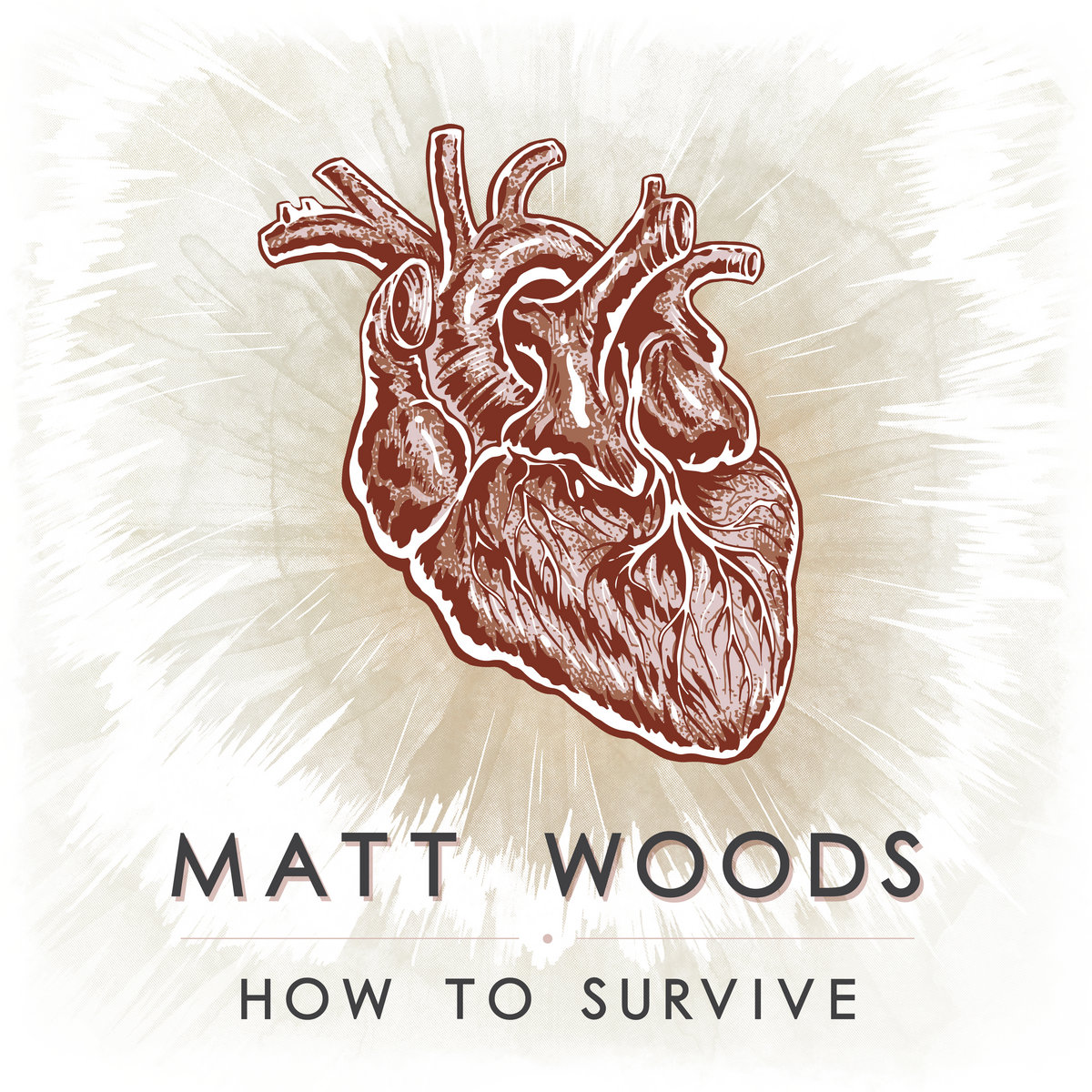L'interesse per una nuova uscita discografica risente molto del desiderio che ho, in quel preciso momento, di ascoltare materiale nuovo di quel determinato artista. Perciò, se nel corso del 2016 sono stato forse più magnanimo del dovuto con le release di Ben Harper e Metallica è solo perché quei dischi mi hanno fatto i grattini proprio dove musicalmente mi prudeva.
Al contrario, quando a giugno è uscito Folfiri o folfox, l'ultimo lavoro degli Afterhours, non avevo alcuna voglia di immergermi nelle insidiose atmosfere di Manuel Agnelli, nonostante il mio affetto sconfinato e la mia imperitura gratitudine nei confronti di questa band.
Non ha aiutato di certo venire a sapere che l'album sia stato ispirato dalla morte del padre di Agnelli e che il titolo dello stesso riprendesse il nome di alcune tipologie di trattamento chemioterapico. Non ha aiutato infine l'ascolto della traccia d'apertura, Grande, che, tra liriche traboccanti e struggente interpretazione vocale, ho trovato troppo dolorosa per proseguire anche solo con la canzone successiva.
Se ho superato questo blocco quasi psicologico e da oltre un mese mi sono immerso nelle note di questo doppio CD , bisogna ringraziare (è proprio il caso di dirlo) le indirette insistenze del mio blogger di riferimento Jumbolo, nonchè di altri amici con i quali da anni ormai scambio via web impressioni e suggerimenti musicali.
Ebbene sì. Folfiri e folfox vale tutta l'attenzione richiesta per entrare in un opera non torrenziale dal punto di vista della durata (per essere un doppio, si attesta comunque sotto i settanta minuti), ma sicuramente impegnativa per i diversi mood dai quali è attraversata. Il lavoro non è solo l'elaborazione di un lutto atteso ma non meno destabilizzante, comunicato in maniera quasi epidermica da composizioni come Grande o L'odore della giacca di mio padre. Gli Afterhours riescono infatti nell'impresa di tornare a realizzare inni generazionali sghembi, così come gli riusciva negli anni di maggiore creatività, ma con la lucida consapevolezza della raggiunta maggiore età, come avviene magistralmente per Il mio popolo si fa.
Ma dicevamo dei diversi umori stilistici che attraversano il disco. Attraverso le diciotto tracce assistiamo come ad un excursus dell'intera carriera della band, che passa agevolmente da suoni acidi, a pezzi quasi improvvisati, a brani in linea con la tradizione cantautoriale italiana, alle tipiche pop songs di casa fino a rimandi ai settanta più sperimentali che richiamano l'ultimo Padania.
Più di ogni altra cosa, Folfiri o folfox contiene Le Canzoni. Oltre a quelli già citati, pezzi come Non voglio ritrovare il tuo nome, Qualche tipo di grandezza, Fa male solo la prima volta o Se io fossi il giudice, a differenza degli ultimi lavori in studio (mi riferisco in particolare a I milanesi ammazzano il sabato e Padania), hanno tutte le carte in regola per acquisire la longevità dei pezzi storici della band.
Credo che tra i gruppi italiani protagonisti di una decade (quella dei novanta), irripetibile per intraprendenza, coraggio e trasversalità della proposta artistica (Marlene Kuntz, Subsonica, Mau Mau, Modena City Ramblers, 99 Posse solo per citare i primi che mi sovvengono), gli Afterhours siano probabilmente gli unici ad essere ancora in grado di competere con la qualità delle composizioni di quegli anni. Al netto di tutte le polemiche (che considero insincere e ipocrite) per le scelte mainstream di Agnelli.
In fin dei conti la risposta migliore a quanti hanno puntato il dito contro l'ultima partecipazione di Manuel a X-Factor in qualità di giudice, è proprio un disco totalmente indipendente e senza compromessi come Folfiri o Folfox.