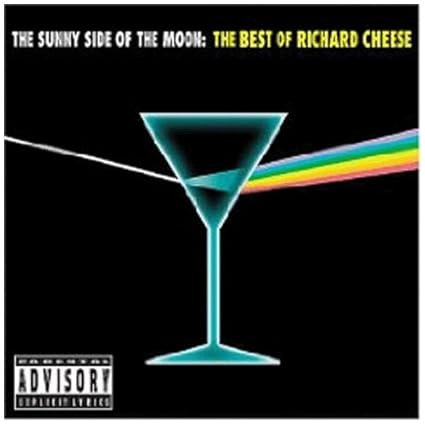Lo ammetto, sono tra quelli che si è stupito dell'indirizzo folk di Ashes & dust, ultimo lavoro di quell'anima irrequieta che risponde al nome di Warren Hanyes. Accantonati gli Allman Brothers Band e, per il momento i Gov't Mule, il talentuoso chitarrista non ha pensato nemmeno per un attimo di prendersi una pausa dall'attività musicale, dando invece nuovo impulso alla carriera solista. Ora, tutti sanno che Warren è un onnivoro musicale, uno che, per dire, dal vivo con i muli passa agevolmente dai Black Sabbath a Prince e che la sua ultima produzione solista aveva un'impronta soul (Man in motion, 2011), ma, per qualche strana ragione, nessuno aveva considerato che potesse avere anche un'anima profondamente rurale.
Ci pensa lo stesso Haynes a spiegare le ragioni di questa scelta, nelle note scritte di proprio pugno all'interno del booklet del cd, dove si concentra sui primi anni della sua formazione musicale, quando era adolescente e bazzicava i locali della zona di Asheville, nella natia North Carolina, dove, perlappunto, il folk (così come il blues) era di casa. E' in questo contesto che sente per la prima volta brani quali Glory road, Coal tattoo e Stranded in self-pity, che sono tra gli highligths di questo disco.
Ma il leader dei Gov't Mule, per raccordarsi degnamente con la sua primissima fulminazione musicale, ha scelto di non fare questo viaggio da solo o accompagnato da anonimi sidemen. Ha deciso invece di condividere il processo creativo di sviluppo delle sue idee, delle sue canzoni (alcune riposte per anni in un cassetto), insieme ad una formazione strutturata e dalla storia ben radicata: i Railroad Earth (quindici anni di attività e sette album all'attivo) che, non fosse per la presenza della batteria, sarebbe a tutti gli effetti una string band.
E l'importanza dei Railroads si sente eccome, non solo perchè si dividono con Haynes i titoli sulla copertina del disco, ma in virtù della profonda impronta che lasciano sul mood dell'opera. Il violino, che marchia a fuoco Is it me or you, la traccia di apertura di Ashes & dust, diventa ad esempio l'elemento distintivo di quasi tutto l'album adagiandosi su liriche che si occupano di temi sempre attuali nelle zone più depresse degli states: disoccupazione, salari da fame, esistenze ai margini della società, relazioni difficili. La già citata Coal tattoo è in questo senso esemplificativa, stesa su un tappeto sonoro che rimanda al Mellencamp di Big daddy, la canzone di Billy Edd Wheeler sembra scritta in questi tempi di interminabile crisi economica, e non quarant'anni fa.
Se ho citato Mellencamp e sto per citare Springsteen (New year's eve ricorda molto nell'andamento Dry lighting, da The ghost of TJ) non è perchè Ashes & dust abbia un sound che debba qualcosa ad altri, ingombranti colleghi, ma perchè la fonte alla quale ha scelto di abbeverarsi Haynes è la medesima, non solo musicalmente ma anche dal punto di vista delle storie raccontate, dalla quale hanno tratto linfa i due grandi del rock americano.
E' questa la vecchia/nuova tradizione sonora dentro alla quale si infila Ashes & dust, riuscendo ad armonizzare vecchie canzoni dimenticate insieme a struggenti composizioni inedite, come la splendida Company man, o, ancora, inaspettate cover come Gold dust woman dei Fleetwood Mac, interpretata insieme alla singer di americana Grace Potter. La propensione jam di Warren emerge verso il finale, attraverso le note Spots of time (scritta insieme a Phil Lesh dei Grateful Dead), mentre l'impronta Gov't Mule è liberata nelle conclusive Halleluja boulevard e Word on the wind.
L'album satura quasi per intero gli ottanta minuti consentiti dal supporto digitale ma, credetemi o no, sarà per l'umore malinconico di questi ultimi mesi, non lo accorcerei nemmeno di un minuto. Così come non rinuncerei al bonus cd contenente quattro pezzi in versione demo/acustica e uno (Hallelujah boulevard) in versione live.
L'ho fatta un pò lunga. Chiudo allora limitandomi a posizionare pleonasticamente Ashes & dust tra le assolute eccellenze del 2015 e lasciando ogni commiato direttamente alle parole del suo autore.
"All the songs here represent special memories to me, and I am very excited to have finally recorded a collection, hopefully the first in a series, of these types of songs that have been a big part of my musical spirit for my whole life."
W.H.