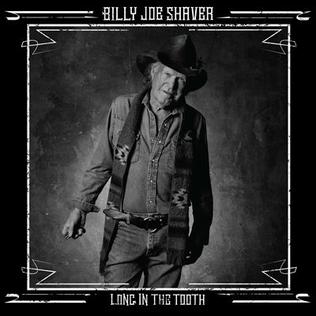All'inizio dovevamo vedere gli AC/DC. Non lo dico per giustificarmi, non mi vergogno per niente di aver assistito al concerto dei One Direction con mio figlio. Anzi, sono più che felice di aver condiviso insieme a lui questa sua prima volta. Ma, sul serio, qualche mese fa, quando si era sparsa la voce di un nuovo tour mondiale degli australiani, avevamo pattuito di andare a vederli (Stefano adora Thunderstruck e You shook me all night long) qualora fossero passati dalle nostre parti. Il rumor si è poi rivelato non veritiero (per dirla tutta, dopo la notizia del tour è circolata la voce di segno opposto di uno scioglimento della band a causa di una grave malattia che ha colpito Malcom Young) ma tanto è bastato per farci assumere l'impegno di assistere asap (as soon as possible) al primo concerto che riscontrasse anche solo un poco del nostro interesse.
Ora, i One Direction non sono esattamente i cantanti preferiti da Stefano ("piacciono alle ragazze" la solida motivazione portata al dibattito), ma immagino che oggigiorno siano un po' la tassa da pagare per i teen ager che attenzionano la musica.
Semplice curiosità o interesse vero, qualunque possa essere stato l'elemento che ha fatto scattare la molla, l'adesione di mio figlio alla proposta di tornare a San Siro, stavolta per assistere ad un evento musicale e non ad una partita di calcio, è stata immediata. Io, con la sicumera del matusa, non mi sono preoccupato di recuperare in anticipo i biglietti, nella convinzione che il gruppo terzo classificato all'X-Factor britannico del 2010 non riuscisse a riempire due serate alla scala del calcio. Ebbene, questo errore di valutazione ha rischiato seriamente di rendermi artefice di una cocente delusione ai danni del ragazzo.
Infatti, nonostante l'anticipo di due ore con il quale arriviamo allo stadio il 29 giugno, le mie certezze sulla facilità di trovare i tagliandi vacillano. Laddove, quando c'è disponibilità di tagliandi i bagarini ti fanno la posta già ad un paio di chilometri da piazzale Lotto, ci troviamo invece a camminare tranquillamente fino ai cancelli senza che nessuno si proponga. Al contrario, pullula di persone che agitano il cartello "compro". L'apprensione che aveva cominciato a prendermi lo stomaco si trasforma ora interrore puro. Nonostante gocce di sudore freddo mi imperlino la fronte faccio finta di niente per non allarmare Stefano, ma ovviamente penso che il premio di peggior papà del mondo non me lo toglierebbe nessuno se l'avessi pompato per l'evento per poi farlo tornare a casa con le pive nel sacco.
Finalmente, dopo interminabili minuti di tremenda angoscia, veniamo avvicinati da un buon samaritano che ci propone un prato a cinquanta euro (il prezzo originario è di trenta). Sollevato, inizio l'inevitabile trattativa e quando troviamo una possibile mediazione intorno ai quaranta accade l'imprevisto: arriva la Guardia di Finanza e comincia a sequestrare i biglietti ad un gruppo di bagarini complici amici di quello con il quale sto mercanteggiando. Il tizio si allontana di soppiatto lasciandomi il corpo del reato (i biglietti) tra e mani, intimandomi con lo sguardo e il movimento all'insù del mento di seguirlo per effettuare il pagamento in luogo sicuro. Così, qualche decina di metri più avanti, sgancio, con una disinvoltura modello Bodie in The Wire, quattro banconote da venti ad un altro del giro che fa segno al mio che è tutto okay. Si può entrare.
Già all'esterno dello stadio si sentiva distintamente, ma una volta dentro l'effetto diventa un onda in piena. L'entusiasmo del pubblico è incontenibile. Sul palco c'è la band di supporto e i ragazzini che affollano spalti e prato si scatenano sostenendoli a pieni polmoni. Il gruppo è quello dei 5 Seconds of Summer, combo australiano di pop punk per teen agers che, a quanto pare, sta facendo sfracelli con il suo disco di debutto. Perlomeno, a differenza dei 1D, appaiono come una vera band: suonano i loro strumenti (due chitarre basso e batteria) e propongono uno show più assimilabile ai concerti ai quali sono abituato piuttosto che ad uno show televisivo (ambito nel quale invece, come vedremo, si muovono gli headliner).
Il palco è qualcosa di enorme. Occupa due terzi in lunghezza del campo da gioco, ad ogni lato ha degli schermi grandi anch'essi come palchi e al centro una passerella che arriva quasi alle tribune opposte. I 5SOS si destreggiano bene (cosa non difficile, vista la predisposizione dell'audience) e toccano l'apice dell'eccitazione collettiva con il singolo Don't stop piazzato a metà esibizione.

Al termine della loro gig spiego a Stefano che ci vorrà una mezzoretta buona perché attacchino i One Direction, per cui ci mettiamo a girare un po' per ammazzare l'attesa. Tra l'altro nel prato spazio ce n'è abbastanza, visto che il pubblico è tutto ammassato sotto palco e passerella. Attorno a noi, come prevedibile, molte ragazzine in età da scuola media accompagnate da genitori con atteggiamenti che attraversano tutta la gamma delle emozioni, dall'annoiato al partecipe, dall'imbarazzato al divertito. Di rigore il sorriso di complicità scambiato con una mamma che sfoggia una maglietta dei Sex Pistols quando le cade lo sguardo sulla mia dei Pantera.
Mentre i megaschermi ai lati del palco mandano le hit del momento (per dire dell'incontenibile eccitazione dei presenti, anche i video vengono accompagnati da robusti singalong) ci concediamo un'occhiata al merchandising e l'acquisto di una t-shirt dei One Direction che dura addosso a Stefano il tempo di scattare la foto qui sotto, visto il suo ripensamento sul portare in giro sti cinque faccioni che genera la richiesta (esaudita dalla gentile commessa) di scambiarla con una nera riportante il logo dei 5 Seconds, molto più rock style. Un paio di gelati più tardi arriva il momento tanto agognato dai presenti. S'interrompe la musica in diffusione, si spengono le luci e s'illumina lo stage. I cinque One Direction stanno per salire sul palco.
continua...